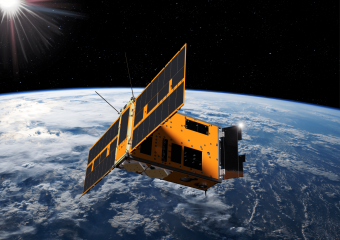Con l’organizzazione dei Mondiali di calcio, nell’estate del 2014, il Brasile monopolizzerà per circa un mese gli interessi di gran parte del sistema mediatico, non solo sportivo. Tendenzialmente un Mondiale è un evento planetario, di massa, che attrae non solo i semplici tifosi/appassionati del gioco del calcio. Da un punto di vista non solo simbolico l’organizzazione del torneo iridato (e delle successive Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016) è la conferma di un paese in pieno fermento economico, seppur ancora ancorato alle contraddizioni sociali di uno rapido sviluppo. Attualmente il Brasile è la sesta economia mondiale, dopo aver scalzato la Gran Bretagna e il tasso di crescita è costantemente attivo.
In quest’ottica gli aspetti culturali e sportivi rivestono un ruolo fondamentale per accompagnare ed assecondare lo sviluppo economico: il fascino della cultura brasiliana ha un ruolo esiziale e un capitale sociale da non disperdere per rafforzare la posizione economica e politica attraverso il soft power.
Tra gli aspetti peculiari del Brasile la passione per il calcio è di gran lunga lo strumento più popolare: ovunque si giochi al pallone il fascino del “calciatore brasiliano” è intramontabile. Una sorta di marchio di fabbrica di un’importante multinazionale. E non è un caso che giocatori brasiliani siano protagonisti in ogni angolo del globo. L’“esodo” è divenuto imponente con l’approvazione della Legge 9.615/98 (o Legge Pelè)(1), che sulla scia della “sentenza Bosman” ha eliminato il vincolo ai giocatori in scadenza di contratto. Secondo le più recenti ricerche (comunque stimate, visto che non tengono conto di giocatori “naturalizzati” o di quelli che militano in campionati dilettanti o semi-amatoriali) i brasiliani all’estero sono circa 6.000. Il trasferimento all’estero dei calciatori è uno dei maggiori prodotti d’esportazione del mercato brasiliano, movimentando annualmente circa un migliaio di calciatori e almeno un centinaio di milioni di dollari. Un mercato enorme (soprattutto se confrontato con i circa 2.000 argentini che militano all’estero, altra nazione d’esportazione di talenti calcistici) che copre pressoché tutti i livelli del calcio mondiale: nel gotha delle più famose e ricche squadre europee (il cosiddetto “G-14”) i brasiliani sono la prima “nazionalità straniera” rappresentata con ben 33 atleti, con alle spalle gli argentini staccati a 19 (Francia 10 e Spagna 6) e sono anche la nazionalità più rappresentata nei primi cinque campionati europei (Inghilterra, Germania, Spagna, Italia e Francia) con ben 120 “legionari”, seguito da Argentina (98), Francia (91), Spagna (37), Olanda (36) e Svizzera (35); nel contempo nei campionati di prima divisione delle ultime dieci nazioni per coefficiente UEFA (San Marino, Andorra, Malta, Fær Øer, Liechtenstein, Lussemburgo, Kazakistan, Azerbaijan, Islanda, Moldavia, Cipro) i brasiliani non calcano i campi della sola Úrvalsdeild, il campionato nazionale islandese. Ma ancora più sorprendente è scoprire la presenza di brasiliani nei campionati del Ruanda (ben tre nell’APR FC Kigali, Alex Silva, Douglas Loper Carneiro, e Diego Oliveiro Alves) o di Mongolia (Emani Mauro nell’Erchim FC), due dei paesi che occupano i luoghi più remoti delle periferie calcistiche. Secondo statistiche rilasciate dalla Confederação Brasileira de Futebol (2), giocatori brasiliani sono presenti in circa il 90% dei campionati riconosciuti dalla FIFA. In soldoni: laddove c’è il calcio c’è un brasiliano.
Brasiliani sono anche presenti massicciamente in altre nazionali, come “naturalizzati”. Di seguito la lista dei brasiliani naturalizzati, suddivisi secondo la nuova cittadinanza calcistica:
Guinea Equatoriale (23, Aldir, Amaral, Anderson Ferreira, Andé Neles, Carlinhos, Danilo, Dio, Fernando Alves dos Santos, Floriano, Jonatas Obina, Jalton, Eduardo Fereira, Judson, Léo Quirino, Mauricio, Nena, Neto, Portela, Ricardinho, Daniel Sabino Martins, Claudiney Ramos Rincón, Ronan, Theo)
Italia (7, Dino da Costa, Anfilogino Guarisi Filó, José Altafini, Angelo Sormani, Octávio Fantoni, Amauri, Thiago Motta)
Timor Est (7, Émerson Cesário, Diogo Rangel, Wellington Rocha, Ramon Saro, Paulo Helber, Alan Leandro, Murilo de Almeida)
Giappone (6, Alex, Wagner Lopes, Ruy Ramos, Marcus Túlio Tanaka, George Yonashiro, Nelson Yoshimura)
Libano (6, Luís Fernandez, Marcílio, Gilberto dos Santos, Jadir Morgenstern, Salomão Salha, Newton de Oliveira)
Togo (6, Alessandro Faria, Hamílton, Cristiano Alves Pereira, Fábio Oliveira, Fabio Pereira, Mikimba Jeferson)
Spagna (6, Catanha, Marcos Senna, Donato Gama da Silva, Diego Da Costa, Rodrigo, Thiago Alcantara)
Azerbaijan (5, Andrezinho, Ernani Pereira, Fábio, Leandro Gomes, Marcos)
Portogallo (5, Cassio, Lùcio, Deco, Liédson, Pepe)
Stati Uniti (4, Alex Ely, Benny Feilhaber, Carlos Metidieri, Jorge Siega)
Bolivia (3, Alex da Rosa, Edivaldo Hermoza, Marcelo Moreno)
Bulgaria (3, Tiago Silva, Lúcio Wagner, Marcos Marquinhos)
Germania (3, Cacau, Paulo Rink, Kevin Kurányi)
El Salvador (3, Nildeson, Israel Castro Franco, Marcelo Messias)
Macedonia (3, Aguinaldo Braga, Gilson Jesus da Silva, Wandeir)
Qatar (3, Marcone, Emerson Sheik, Fábio César)
Tunisia (3, José Clayton, Francileudo Santos, Messias)
Australia (2, Cássio, Agenor Muniz)
Belgio (2, Igor de Camargo, Luis Oliveira)
Croazia (2, Eduardo, Sammir)
Honduras (2, Denilson Costa, Fábio de Souza)
Messico (2, Antônio Naelson Zinha, Leandro Augusto)
Turchia (2, Marco Aurélio [Mehmet Aurélio], Wéderson [Gökçek Vederson])
Vietnam (2, Fábio dos Santos [Phan Văn Santos], Huỳnh Kesley Alves)
Armenia (1, Marcos Pizzelli)
Bielorussia (1, Renan Bressan)
Bosnia-Erzegovina (1, Ricardo Baiano)
Canada (1, Tony Menezes)
Cile (1, Marcos González)
Costa Rica (1, Alexandre Guimarães)
Hong Kong (1, Cristiano Cordeiro)
Israele (1, Gabriel Greener)
Moldavia (1, Luvannor)
Perù (1, Julinho)
Polonia (1, Roger Guerreiro)
Singapore (1, Egmar Goncalves)
Ucraina (1, Edmar Halovskyi de Lacerda)
Ungheria (1, Leandro de Almeida)
Uruguay (1, Matías Aguirregaray)
Trinidad e Tobago (1, Jose Luis Seabra)
Svizzera (1, Henri Siqueira)
Come vediamo il caso più eclatante è quello della Guinea Equatoriale: il piccolo paese centroafricano dal 2005 ha dato il via ad una politica di nazionalizzazioni “facili” anche con calciatori che non avevano nessun legame con il paese. Questa politica è stata patrocinata da Ruslán Obiang Nsue, figlio del presidente Teodoro Obiang, che nel 2004 ha incaricato il commissario tecnico Antônio Dumas di reclutare numerosi calciatori stranieri per la squadra nazionale, sia maschile che femminile. Oltre ai brasiliani sono stati naturalizzati numerosi calciatori e calciatrici provenienti da Burkina Faso, Camerun, Colombia, Ghana, Costa d’Avorio, Nigeria, Liberia, Mali, Senegal e Spagna. L’allenatore brasiliano Dumas è stato protagonista anche delle naturalizzazioni dei sei brasiliani-togolesi.
Situazione ancora più significativa nel futsala, o calcio a 5, nel quale le naturalizzazioni sono ancora più diffuse e abbiamo potuto vedere anche nazionali composte interamente da brasiliani (come quella italiana nel Mondiale 2008 (3), giocati proprio in Brasile, fra non poche polemiche).
Innanzitutto va sottolineato che il Brasile è il primo paese al mondo per popolazione tra quelli che hanno il calcio come sport nazionale de juro o de facto o è lo sport più popolare. Questa i primi dieci paesi al mondo con la specifica degli sport principali: Cina (tennistavolo); India (hockey su prato, cricket); Stati Uniti (pallacanestro, baseball, football americano), Indonesia (badminton), Brasile (calcio), Pakistan (hockey su prato, polo, cricket), Nigeria (calcio), Bangladesh (cricket), Russia (hockey su ghiaccio), Messico (baseball, calcio). Il Brasile è però il quarto paese per numero di iscritti nelle federazioni calcistiche nazionali alle spalle di Cina, India e Germania. Il dato è però poco significativo o comunque parziale: Cina e India guidano la classifica in virtù del ruolo di prima e seconda potenza demografica del mondo, mentre la supremazia tedesca rispetto a quella brasiliana è dovuta in particolare alla migliore strutturazione del calcio teutonico, visto che non sono considerati i numerosi brasiliani che sono a) naturalizzati; b) non tesserati, ma comunque attivi nei livelli più bassi dei campionati interni o all’estero (amatoriali, dilettanti o semi-professionisti); c) i brasiliani che passano dai tornei di calcio a quelli di calcio a 5.
Il campionato nazionale (la prima edizione è appena del 1971) è suddiviso in quattro serie, le prime tre (Série A, B, C) hanno 20 squadre, la quarta (Série D) ne ha 40. Ogni stato federato ha inoltre il suo campionato, con tradizioni ultracentenarie, visto che il Campeonato Paulista nasce ufficialmente nel 1902. Dopo 91 anni con la prima edizione del Campeonato Tocantinense, nel 1993, tutti i 27 stati hanno un campionato statale. 26 stati organizzano anche una segunda divisão, 8 organizzano la terceira divisão, mentre solo il Paulista ha anche una quarta divisão. I club registrati alla federazione sono quasi 800, mentre circa 11.000 sono le squadre amatoriali.
Inoltre il Brasile è un paese di quasi duecento milioni di abitanti, che hanno differente natura etnica (di origine europea, africana o indio), provenienza sociale (dalla ricca borghesia latifondista agli abitanti delle favelas) o geopolitica (il Brasile è una repubblica federale e i diversi stati hanno non poche differenze socio-culturali-politiche tra di loro), da un punto di vista geografico sono classificate almeno cinque macro-aree e da un punto di vista climatico ha una grande varietà di condizioni atmosferiche ed è quindi presente una diversificazione di struttura fisica, mentale, organica e biologica con importanti ricadute sullo sport, che oltre al calcio, garantisce al Brasile numerosi successi (ad esempio nella pallavolo, nel nuoto, negli sport di combattimento o nell’automobilismo).
Analizzando quindi la situazione da un punto strettamente demografico è naturale avere un così grande numero di brasiliani in giro per il mondo.
Più difficile è definire se effettivamente l’acquisto di uno o più calciatori brasiliani garantisca effettivamente uno salto di qualità della squadra, anche perché nel mondo del calcio esiste sostanzialmente un solo dato statistico oggettivo (il numero di gol) che non sempre è garante di buone prestazioni (la storia del calcio è piena di squadre che hanno in rosa il capocannoniere di un campionato ma che non ottengono i risultati prefissati), mentre altri dati che potrebbero essere effettivamente contabilizzati non sono, a differenza di altri sport, decisivi (numero passaggi riusciti, assist, palle rubate, falli, distanza percorsa). Quindi, le classifiche sotto riportate rispecchiano alcuni fattori, alcuni “campi di studio”, ma non hanno la pretesa di essere “definitive”.
Partendo dal dato asettico del numero di gol, possiamo vedere che nei campionati di prima divisione europei (UEFA, stagione 2012-2013 o stagione 2013), oltre ai 19 capocannonieri autoctoni, abbiamo Argentina e Brasile tra le nazioni con il maggior numero di bomber stranieri, tre a testa. I bomber brasiliani sono Clayton Soares do Nascimento, capocannoniere delle Fær Øer (dato che da solo basterebbe per distruggere almeno cinquant’anni di fantasie sulla saudade), Wánderson in Russia e Marcos Tavares in Slovenia. I tre argentini sono capocannoniere in Spagna, Svizzera e Slovacchia. Seguono a quota due i sorprendenti bomber armeni e georgiani, la Colombia, la Francia, l’Inghilterra e la Spagna.
Passando nel quadrante asiatico, un dato salta subito all’occhio, nelle undici edizioni dell’AFC Champions League, in ben 6 occasioni un brasiliano è divenuto capocannoniere (2006 Magno Alves; 2007 Mota; 2009 Leandro; 2010 Mota; 2012 Ricardo Oliveira; 2013 Muriqui).
Impossibile è invece analizzare il rendimento effettivo, se non affidandoci a statistiche giocoforza oggettive, come ad esempio la media voto.
Dei brasiliani che hanno militato nel campionato italiano, nella stagione 2012-13 sono 11 i giocatori che hanno ottenuto una sufficienza netta (>5.9), 18 una leggerissima insufficienza (5.8-5.5; che considerano i voti tendenzialmente bassi dei giornalisti sportivi, potremmo considerarla una sufficienza piena), mentre solo 6 hanno ottenuto una netta insufficienza (<5.5) (4).
A puro titolo esemplificativo, va anche analizzata la situazione storica dei cosiddetti “bidoni”, cioè quei calciatori stranieri che hanno clamorosamente fallito nel campionato italiano. In questo caso la soggettività è ancora più accentuata (laddove l’aspettativa per l’acquisto gioca un ruolo fondamentale), ma prendendo come “punto di riferimento” un blog che è una vera e propria istituzione in materia (5), notiamo come sui 150 “fallimenti” censiti, ben 24 sono brasiliani (6), con i francesi fermi appena a 14 e gli argentini 11. Per la cronaca, almeno 4 tra questi “bidoni brasiliani” giocarono in Italia durante un periodo non particolarmente brillante di carriere altrimenti di altissimo livello (Rivaldo, Edmundo, Jardel e Socrates).
Quindi con i dati finora presentati, se pur parziali, possiamo dire che i brasiliani sono tendenzialmente buoni investimenti, visto che garantiscono prestazioni affidabili, creano grandi aspettative e sono facilmente adattabili in ogni angolo del globo.
Ma quanto scritto non spiega il così vasto esodo dei calciatori brasiliani. Quali sono quindi i motivi che spingono i brasiliani a diffondersi a macchia d’olio in ogni angolo dell’universo calcistico? Perché nel resto del mondo troviamo moltissimi giocatori brasiliani e pochi tedeschi? Prevalentemente le motivazioni principali sono:
1- motivazioni di carattere economico;
2- “fascino” esercitato dal calciatore brasiliano;
3- sovrabbondanza di calciatori brasiliani in determinati ruoli;
4- missione globale del calcio brasiliano
L’aspetto economico è sicuramente preponderante. In Brasile un calciatore guadagna mediamente molto meno rispetto ad un calciatore che milita nei campionati europei. Secondo recenti statistiche appena il 2% dei calciatori professionisti in Brasile guadagna sopra 12.440 real (circa 4.000 euro), il 16% guadagna tra 1.244 (circa 400 euro) e 12.440 real e ben l’86% guadagna meno di 1.244 real (7). In definitiva, con un buon procuratore, un giocatore di una serie D in Italia (la quinta divisione nazionale) può guadagnare più di un brasiliano di serie B e uno stipendio di 400 euro corrisponde, più o meno, ad un rimborso spese che in Italia è possibile ottenere anche nelle ultime categorie dilettantistiche.
Secondo la Banca Interamericana di Sviluppo le rimesse dei calciatori brasiliani che militano all’estero sono una cifra significativa: nel 2004 erano 5,6 miliardi di dollari, nel 2005 6,4 miliardi, 2006 7 miliardi. Considerando che i brasiliani all’estero sono in costante aumento, le cifre sono sicuramente aumentate rispetto a sette anni fa.
Strettamente legato all’aspetto finanziario è il “fascino” esercitato da un giocatore brasiliano, a tutte le latitudini. È fin troppo evidente che l’acquisto di un calciatore straniero provoca un’impennata di entusiasmo tra i tifosi, il che significa per la società un aumento di fatturato (abbonamenti, biglietti, televisioni, sponsorizzazioni, vendita di oggetti legati alla squadra, ecc). Esistono però nazionalità che, grazie alla buona pubblicistica e alla nomea, creano una maggiore aspettativa, come i brasiliani, gli argentini, gli spagnoli (tendenzialmente i giocatori più passionali, “caldi” o spettacolari), mentre altre ne creano di meno (difficilmente un tifoso si entusiasmo per un difensore centrale svedese o per un centromediano austriaco). Ecco quindi che il “fascino” diventa una leva negoziale tra il venditore (procuratore o società proprietaria del cartellino) e l’acquirente (la società interessata). Ogni buon procuratore, anche tra i meno famosi, ha una “carta brasiliana” da giocare nelle più svariate trattative. Tendenzialmente è un “rischio d’impresa” relativamente basso e potenzialmente redditizio, tanto più se un giovanissimo calciatore non viene scientemente tesserato da società in patria, sono evitate le lungaggini burocratiche e le “indennità di formazione” regolarizzate dalla FIFA, come confermato dall’avvocato Jean-Christophe Cataliotti, agente FIFA: «a volte i calciatori scientemente non vengono tesserati nel loro Paese di origine proprio per agevolarne il tesseramento presso altra Federazione. E’ il caso, ad esempio, dei calciatori brasiliani che, se scovati da bravi talent scout, vengono portati in Europa senza che siano mai stati tesserati nel loro Paese di origine. Il giovane calciatore avrà così maggiori possibilità di essere tesserato! E probabilmente tutti le parti coinvolte faranno un grosso affare!» (8). Un sotterfugio, come quello delle facili naturalizzazioni o della falsificazione delle date di nascita (9), che si innesta in un mercato “drogato”, anche perché legato non solo alle logiche del risultato sportivo, ma anche a quelle del profitto e dell’attrattiva rispetto ad un marchio. A risentirne è anche lo sviluppo dello sport in Brasile, come confermato anche dall’allenatore Arsene Wenger: «il trasferimento di giocatori sempre più giovani in Europa sta distruggendo il calcio brasiliano». Nell’interessante libro “Calcionomica” gli autori, il giornalista Simon Kupfer e l’economista Stefan Szymanski, mettono in guardia dal “fascino” esercitato dal calciatore brasiliano: «il paese più di moda nel mercato calcistico è il Brasile. Come scrive Alex Bellos in Futebol: lo stile di vita brasiliano: «L’espressione “calciatore brasiliano” è come “chef francese” o “monaco tibetano”. La nazionalità indica un’autorevolezza, una naturale vocazione per quel ruolo, che va al di là delle naturali capacità del singolo». Un procuratore brasiliano che aveva esportato diversi mediocri calciatori suoi connazionali in posti come le isole Faer Oer e l’Islanda raccontò a Bellos: «È triste dirlo, ma è molto più facile vendere, per fare un esempio, un brasiliano scarso che un eccellente messicano. I brasiliano porta con sé l’immagine della gioia, della festa, del Carnevale. Indipendentemente dal talento, l’idea di avere un posto in squadra è allettante» (10).
L’alta spettacolarità del futbol bailado prevede una specializzazione in determinati ruoli fondamentali, nei quali il paese sudamericano ha sovrabbondanza: «Storicamente la scuola brasiliana ha prodotto grandi terzini di fascia, grandi centrocampisti offensivi e attaccanti mentre è sempre stata abbastanza carente nei ruoli difensivi»(11), anche se nell’ultimo decennio la globalizzazione delle tattiche calcistiche e l’influenza del calcio europeo ha prodotto una sequela di portieri e difensori centrali (con conseguente “moda” nell’acquisto di questi nuovi “specialisti”).
Tecnici come Vanderli Luxemburgo e Carlos Alberto Pereira si sono dimostrati molto critici nei confronti di questo mutamento dello “stile brasiliano”, in forma più difensivista, cinico e pratico, con tecnici come Carlos Dunga messi alla gogna mediatica per il calcio troppo “europeo”, e poco avvincente, giocato dalla sua nazionale. La passione popolare brasiliana per lo stile brasileiro rappresenta anche una forma di resistenza alla globalizzazione e a quel processo che porta Eric Hobsbawm a dire che il calcio globale sta combattendo le identità nazionali: «lo Stato nazione si sta sgretolando, ma non ne possiamo fare a meno. Come il football dei ricchi club deve convivere con le nazionali, perché il mondo non è globalizzabile fino in fondo». E forse non è un caso la dichiarazione dello storico: «Nessuno nelle recensioni di Globalisation, Democracy and Terrorism si è occupato del capitolo sul calcio. Con un’eccezione che non vi sorprenderà: i brasiliani»(12).
Un diffuso “luogo comune” sul calcio brasiliano sostiene che “il Brasile ha talmente tanti giocatori di alto livello che potrebbe fare tre-quattro nazionali ugualmente forti”. È, come tutti i “luoghi comuni” una verità solamente parziale: i brasiliani hanno abbondanza di giocatori nei ruoli “classici”, mentre spesso hanno carenze imbarazzanti in altri. Un esempio classico è il Brasile del 1982, quello che è considerato come il più forte di tutta la storia, che aveva abbondanza di “piedi buoni” e talenti a centrocampo (Falcao, Cerezo, Socrates, Junior, Zico, Eder), due “onesti pedalatori” al centro della difesa (Oscar e Luisinho), una prima punta decisamente di livello basso (Silvinho) e un portiere totalmente inadeguato (Valdir Peres). Situazione simile a quanto si assiste nella preparazione al Mondiale 2014: una pletora di trequartisti e registi, mentre manca il classico centroboa, con il commissario tecnico Luiz Felipe Scolari costretto a rilanciare un ex attaccante di buone speranze come Fred o a battagliare con la Spagna per “riacquisire” lo scartato Diego Costa.
Questa abbondanza è un fattore economico fondamentale nell’esportazione di calciatori brasiliani: se una squadra cerca un regista geniale e concreto oppure un terzino fluidificante di grande corsa e tecnica, può puntare ad occhi chiusi su un brasiliano, vista l’alta specializzazione in questi determinati ruoli. L’alta specializzazione in alcuni ruoli inoltre permette a brasiliani anche di livello medio-basso di “vivere di rendita” in campionati di più basso livello, soprattutto laddove la preparazione tecnico-tattica è tutt’altro che curata e la fisicità è posta in primo piano, come ad esempio nei campionati asiatici.
Ma c’è un aspetto, forse quello più importante, che porta i brasiliani a giocare in ogni parte del mondo: esiste una sorta di “missione”, quasi messianica e mistica (13), nel calcio brasiliano. I brasiliani devono diffondere il loro verbo calcistico a chi “ha meno fortuna”, perché non conosce il piacere del futbol bailado. Ma non hanno intenzione di “insegnare il calcio”, come hanno pretesa altre categorie, come gli allenatori olandesi, i “maestri inglesi”, o alcuni soloni italici, ma vogliono “spiegare il calcio”, spiegare al resto del mondo quello che per i brasiliani è, romanticamente, il “sogno di un bambino”. Questa “missione” è ben rappresentata dalla frase che Zico ha recentemente dichiarato in merito al Mondiale del 1982: «la vittoria dell’Italia (contro il Brasile, 3-2, nda) ha fatto male al calcio, non fu positiva per il mondo del calcio. Se avessimo vinto quella partita il calcio probabilmente sarebbe stato differente»(14). Quella che in Italia fu presa come un’offesa alla “dignità nazionale”, tanto che con la proverbiale incompetenza giornalisti ed addetti ai lavori hanno ribadito che «l’Italia ha vinto con merito» (cosa mai messa in dubbio da Zico, che dichiarò anche «Se quel giorno avessimo segnato cinque reti, l’Italia ne avrebbe segnate sei, perché trovavano sempre il modo di capitalizzare i nostri errori», confermando il “merito degli azzurri”), rappresenta la summa dell’ideologia calcistica brasiliana: “non mettiamo in dubbio che gli italiani abbiano vinto con merito, ma non hanno capito niente. Il “calcio brasiliano” è il vero calcio ed è scopo dei brasiliani spiegarvelo”.
L’internazionalismo del calcio brasiliano ha radici fin dalla fondazione del movimento sportivo brasiliano: se come in gran parte del mondo sono gli inglesi ad esportare il nuovo sport nella seconda metà del diciannovesimo secolo, in Brasile il calcio si internazionalizza subito. Tedeschi, italiani, inglesi, diventano subito protagonisti del calcio ufficiale, mentre i brasiliani poveri, i mulatti, gli eredi degli schiavi provenienti dall’Africa diedero impulso al “calcio da strada”, il futbol de várzea. Alcune date risultano simboliche in questa internazionalizzazione del calcio: il 14 aprile 1895 prima partita ufficiale a Sao Paulo; il 18 agosto 1898 è fondata la Associação Atlética Mackenzie College, prima squadra calcistica, formata da collegiali di origine europea; nel 1899 è fondato Sport Club Internacional, prima società che si occupa solo di calcio, in cui militano giocatori originari di tutto il mondo; 7 settembre 1899 Sport Club Germânia, formazione di riferimento della comunità tedesca. I primi due craque del campionato nazionale sono Charles William Miller (inglese) e Hermann Friese (tedesco) (15).
Non è un caso inoltre che la prima super-stella del calcio verdeoro fu Arthur Friedenreich, figlio di un commerciante emigrato dalla Germania, Oscar, e madre lavandaia afro-brasiliana, Matilde. Simbolo stesso di una nazione e della sua identità calcistica che nasce dalla simbiosi tra la struttura elitista del calcio organizzato e quella anarchica del calcio da strada. Identità diventata ufficiale appena nel secondo decennio del 1900: il 5 settembre 1910 nasce Sport Club Corinthians Paulista, prima squadra ad accettare mulatti e di colore, e nel 1918 Federação Brasileira de Esportes autorizza tutte le squadre ad inserire negli organici anche i negri e i mulatti. È il primo passo che porta al professionismo, ufficiale dal 1929, passaggio che rompe definitivamente la struttura elitista e biancocentrica del calcio ufficiale brasiliano, non più un passatempo per ricchi, ma uno sport di massa.
La commistione identitaria internazionalista del calcio brasiliani si rivela in un altro fondamentale snodo della storia del paese, con il primo Campionato Mondiale vinto nel 1958, grazie ad un’intuizione proveniente della Mitteleuropa: «il 4-2-4 si consacrò in Brasile nel 1957 grazie ai successi riportati dal San Paolo, allenato dal magiaro Bela Guttman, e della Nazionale brasiliana che nel 1958 vinse il suo primo mondiale giocando proprio con il 4-2-4» (16).
In uno stato in cui la multietnicità è un fattore identitario e non un’imposizione dettata dagli imponenti flussi migratori interni al sistema capitalistico-imperialista e causati dalla geopolitica del caos, l’internazionalismo dello sport più popolare è un motivo d’orgoglio, una forma di riscatto sociale e una missione dai tratti quasi mistici. Il sociologo Marcos Guterman (17) mette in evidenza come «in Brasile il calcio sia parte integrante della storia del paese e che, quando si parla di calcio, in Brasile si parla non solo di un gioco, ma della storia stessa del Brasile»(18).
In conclusione possiamo affermare che quello che è considerato lo sport più “globale” (19) in realtà ha solo il “fattore” Brasile come elemento realmente e genuinamente globalizzante, sia nella diffusione sia nell’identità calcistica, laddove altri paesi, proprio nella partecipazione all’evento sportivo riscoprono le proprie identità nazionali.
NOTE
(1) «La nuova legge elaborata dal ministro dello sport Pelé’ lascia alle società che hanno formato il giocatore soltanto l’opzione prioritaria per firmare il suo primo contratto di professionista, ma con una durata che non può superare i due anni» Legge Pelé: rischio di “esodo cartellini”, Gazzetta dello Sport, 27 marzo 1998
(2) Fondata appena nel 1979, precedentemente la federazione competente era la Confederação Brasileira de Desportos.
(3) Questi gli “azzurri” del Mondiale 2008: Alexandre Feller, Grana, Pellegrini, Jocimar Jubanski, Clayton Baptistella, Edgar Bertoni, Marcio Forte, Saad Assis, Fabiano, Adriano Foglia, Morgado, Farina, Sandro Zanetti, Patrick Nora. Per la cronaca, l’Italia mancò la finalissima per una contestata autorete. Nel caso di approdo in finale avrebbe incontrato proprio il Brasile, in un incredibile finale mondiale con soli brasiliani in campo.
(4) Media voto della Gazzetta dello Sport
(5) http://www.calciobidoni.it/
(6) Per la cronaca: Amaral, Andrade, Athirson, Beto, Bianchezi, Caio, Cribari, Danuello, Edmundo, Eneas, Fabio Junior, Gilberto, Jardel, Luvanor, Ricardo Oliveira, Pedrinho, Pereira Orlando, Renato Portaluppi, Rivaldo, Roque Junior, Socrates, Toffoli, Tuta, Vampeta.
(7) http://marketingesportivopucrio.blogspot.com/2013/11/dificuldades-financeiras-o-destino-do_8674.html
(8) http://www.fcinter1908.it/ultim-ora/cataliotti-ecco-quanto-costa-un-giovane-calciatore-proveniente-dall-estero-97493
(9) Pratica molto in voga in Africa, ma che non è sconosciuta anche in altre zone. Eclatante il caso del brasiliano Luciano, arrivato in Italia come Eriberto con una falsa data di nascita.
(10) Simon Kupfer e Stefan Szymanski, Calcionomica, pag. 35
(11) Francesco Scabar, Tattica: principi, idee, evoluzioni, opera inedita
(12) Guido Santevecchi, Hobsbawm: il calcio globale contro le nazioni, Corriere della sera, 7 ottobre 2007
(13) Le reazioni alla sconfitta nella partita decisiva del Mondiale contro l’Uruguay nel 1950 (il “disastro del Maracanã” o “O Maracanaço” in portoghese) sembrano in effetti più un una forma rituale di carattere quasi religiosa piuttosto che una degenerata passione sportiva: suicidi (ben 34, con 56 morti per infarto), drammatici titoli dei giornali (che parlavano di “tragedia” o di “nostra Hiroshima”), giocatori che cadono in depressione (il difensore Danilo Alvim Faria) o vengono considerati dei reietti (il portiere Moacir Barbosa).
(14) https://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/calcio/2012/11/28/Zico-Italia-Brasile-3-2-male-il-calcio_7867946.html
(15) vedi Luciano Sartirana, Nel Settimo creò il Maracanà, Edizioni del gattaccio (vera e propria enciclopedia del calcio brasiliano!)
(16) Francesco Scabar, Tattica: principi, idee, evoluzioni, opera inedita
(17) Marcos Guterman, O futebol explica o Brasil. Uma história da maior expressão popular do país, São Paulo, Contexto.
(18) Domenico Branca, “Serás eterno como el tiempo y florecerás en cada Primavera”. La squadra di calcio come fenomeno identitario, Anuac, Anno I, Numero 1, giugno 2012
(19) È la teoria di fondo del libro di Pascal Boniface, La terra è rotonda come un pallone. Geopolitica del calcio, il Minotauro, 2004
![Share on Facebook facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()
![Share on Facebook facebook]()
![Share on Google+ google_plus]()
![Share on Reddit reddit]()
![Pin it with Pinterest pinterest]()
![Share on Linkedin linkedin]()
![Share by email mail]()